La suggestiva Chiesa di S. Maria Nova a Toffia è stata edificata certamente sui ruderi di un edificio altomedievale sul quale aleggiano varie opinioni circa la sua origine, attribuita sia ai Longobardi
Chiesa di S. Maria Nova
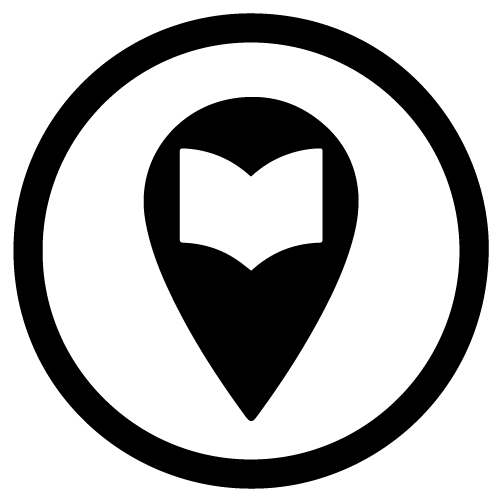
Posizione
Via Monte Cavallo, 33
02039 Toffia (RI)
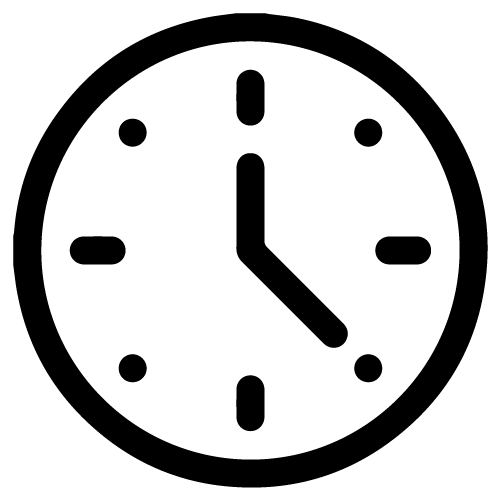
Orari di apertura
Aperta durante le funzioni religiose
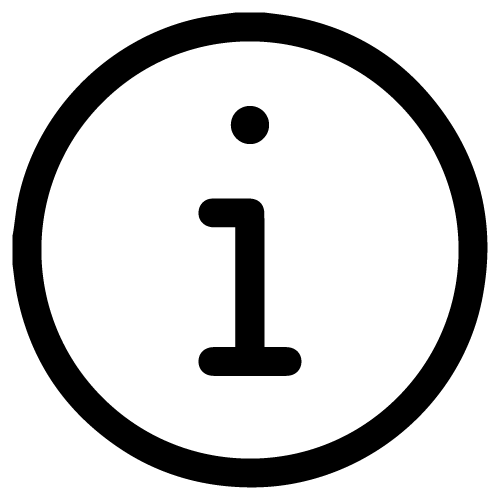
Contatti
Tel.
Mail:
La suggestiva Chiesa di S. Maria Nova a Toffia è stata edificata certamente sui ruderi di un edificio altomedievale – probabilmente un palatium – sul quale aleggiano varie opinioni circa la sua origine, attribuita sia ai Longobardi che alla famiglia dei Colonna; anche il fatto di chiamarsi S. Maria Nova potrebbe sia richiamare l’esistenza in loco di una chiesa preesistente, che la necessità di sostituire la vicina chiesa della Madonna di Loreto (S. Maria di Piazza), divenuta troppo piccola per accogliere la popolazione del castello.
Unica certezza che la prima pietra di questa Nova chiesa è stata posta il 2 luglio del 1507, e per questo dedicata alla Visitazione della Vergine a santa Elisabetta, che si celebrava il 2 luglio prima della riforma di Paolo VI . Purtroppo anche questa nuova costruzione è andata semidistrutta da un incendio, nella notte tra il 31 dicembre del 1981 e il 1 gennaio del 1982, a seguito del quale sono andati distrutti gran parte degli affreschi, la pala d’altare con una Visitazione di Vincenzo Manenti (1600-1674), il prezioso altare ligneo del 1600 “con sei colonne doriche” di quel Michelangelo da Toffia che aveva realizzato anche il coro dell’Abazia di Farfa, l’organo del seicento, gli stalli del coro, un antifonario del 1500 e molto altro ancora.
La chiesa è stata riaperta al culto nel novembre del 1995.
ESTERNO
Sulla facciata scarna e severa, una duplice rampa di scale contrapposte permette di accedere al portale d’ingresso, sovrastato da un architrave con la scritta SOL IVSTITIAE DEVS (Dio sole di giustizia) e da un timpano che un tempo conteneva un affresco della Vergine col Bambino e S. Lorenzo; all’apice del timpano una piccola epigrafe difficilmente leggibile, ricorda chi ha contribuito all’installazione dei portoni : “Elevatio ianuae expensi comitatis Prioribus D.D. Lazzaro Merculino, Andrea Rizzello, Julio Cesare Jacobatio et Petro Paolo quondam Caroli. Anno Domini 1696“.
Più in alto, sono presenti un finestrone circolare e due finestre più piccole ai lati. Sulla sinistra si erge il possente campanile che si vuole eseguito su disegno di Michelangelo Buonarroti. Alla base della scala e del campanile, una delle lastre di rivestimento è un’epigrafe sepolcrale di epoca romana ormai illeggibile, di cui si distinguono oggi a mala pena le tre lettere rituali di inizio: D. O. M., vale a dire “a Dio (Giove) Ottimo Massimo”. A destra del portale della chiesa, sopra l’entrata della casa parrocchiale, è inserito nel muro lo stemma di Pio XI raffigurante un’aquila che sovrasta tre palle, affisso sulle proprietà ecclesiastiche dopo la firma dei Patti Lateranensi.
INTERNO
L’impianto della chiesa attuale risale ai primi del Cinquecento e risente degli influssi rinascimentali, con spazi luminosi e sobriamente movimentati. Alla originale navata unica, si sono per così dire affiancate due piccole navate laterali scandite da archi che poggiano su tre pilastri divisori, resisi necessari per sostenere il tetto così come ordinato nella Visita Pastorale del 1776 . All’abside della navata centrale, preceduta da un arco trionfale, si affiancano due più piccole absidi laterali, alle estremità del transetto che forma la croce latina della pianta.
Sulla controfacciata, vi è uno degli affreschi cinquecenteschi salvatisi dall’incendio del 1981, sotto il quale sporge la trave bruciata che sosteneva la cantoria con l’organo. Al di sotto, in una nicchia ricavata nel muro e chiusa da un’artistica inferriata, si trova una pregevole fonte battesimale in marmo del XVI secolo. Sopra il portale d’ingresso è affissa una grande tela seicentesca, raffigurante la Madonna e il Bambino in gloria, mentre a destra spicca un grande crocifisso ligneo (XVIII secolo?) proveniente dalla Chiesa della Madonna di Loreto.
Negli angoli 2 epigrafi ricordano i restauri effettuati: a sinistra il cardinale Luigi Bilio, essendo pontefice Leone XIII, con il concorso economico dello stato e dei cittadini, restaurò la chiesa; a destra il restauro finanziato dall’arciprete Pietro Stella nel 1880.
Sui lati della chiesa si aprono una serie di cappelle, che recavano – prima dell’incendio – sugli altari gli stemmi delle famiglie gentilesche di Toffia che ne finanziavano l’abbellimento e la manutenzione.
Oggi troviamo, sul lato sinistro:
Prima cappella: Tela seicentesca di autore ignoto, con S. Giovanni e S. Paolo ai piedi della Vergine con il Bambino tra le braccia
Seconda cappella dell’Immacolata Concezione: La pala dell’altare è costituita da un frammento di un anonimo affresco cinquecentesco, in cui due angeli posano la corona sul capo della Vergine con il Bambino in braccio. In basso a destra, su un’iscrizione mutila facente parte dell’affresco, sembra di poter leggere la data 1584.
Il lato sinistro termina con una cappella absidata, che presenta importanti affreschi: almeno due (negli specchi di destra e di sinistra dell’altare) sono con sicurezza da attribuirsi a Vincenzo Manenti ma è probabile che anche quelli della cornice dell’arco siano opera sua o almeno di qualche allievo di buon livello, vista anche la loro precisa somiglianza con quelli presenti nelle cappelle della navata sinistra della Chiesa di S. Maria di Farfa.
Sul lato destro:
Tutto il contenuto della cappella absidata di destra è andato perduto nel corso dell’incendio. La pala d’altare attuale è opera dell’ artista contemporaneo Massimo Livadiotti.
Seconda cappella di S. Stefano Protomartire: La pala d’altare è costituita da un delicato affresco di ignoto ma valido artista, databile ai primi decenni del XVII secolo e raffigurante S. Stefano accolto amorevolmente in seno alla Sacra Famiglia. L’opera è attribuita a Vincenzo Manenti.
Prima cappella: L’affresco cinquecentesco che costituisce la pala di questo altare, presenta la classica iconografia della Madonna del Rosario; intorno all’affresco le caselle con i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, sono dipinte a guazzo e attribuite anch’esse al Manenti.











